Si chiama cinipide galligeno, volgarmente detto "vespa del castagno". È un imenottero che deposita le sue larve nei germogli degli alberi. Un'usanza che può avere conseguenze molto gravi: la riproduzione si blocca, il parassita prolifera e infine la pianta muore. "Dal 2011 abbiamo avuto una drammatica infestazione nei boschi alle spalle di Genova", spiega Aimé dati alla mano.
Niente castagni, niente cibo per i cinghiali, che si nutrono soprattutto dei loro frutti. Ecco, quindi, che gli ungulati si avvicinano alla città per trovare nutrimento. Ne trovano soprattutto dove si raccoglie l'immondizia, immancabile meta delle loro scorribande. Se la caccia va a buon fine, significa che si può tornare. E così i suini selvatici diventano urbani, per spirito di sopravvivenza. "Certo, molti poi gli danno da mangiare per pietà - continua Aimè - ma il problema principale sono proprio i castagni".
Ma quanti sono i cinghiali sul territorio di Genova? Secondo Aimè, la quota di abbattimento fissata per legge corrisponde a 13 mila unità all'anno. "Di sicuro ce ne sono di più, anche perché se ne cacciano meno di quanto sia permesso", riflette Aimè. La genetica ci dice che tra cinghiali e maiali la differenza sta solo nell'addomesticamento. Anche loro, in fin dei conti, provano a civilizzarsi. E finché non passerà la linea dura dei fucili dovremo abituarci a vederli trottare sulle strade, mamma papà e figli: da qualcuno odiati, dai più tollerati e da alcuni persino amati.
 15° C
15° C LIVE
LIVE


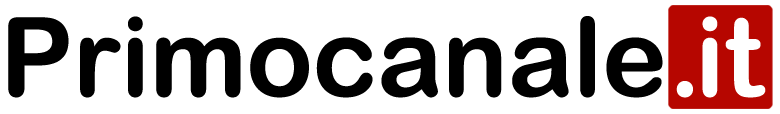
IL COMMENTO
-
Mario Paternostro
Domenica 20 Aprile 2025
-
Franco Manzitti
Sabato 19 Aprile 2025
leggi tutti i commentiLe strade dei “ragazzi partigiani” che raccontano gli eroi del 25 aprile
Ti ricordi Sergio Castellaneta, un anticipatore populista e non solo