 Se Molière una volta disse che “tra le tante seccature che l’uomo ha inventato, l’opera è la più costosa”, qualche motivo l’avrà pure avuto. E questo quattro secoli prima di poter valutare la drammatica situazione in cui, per un motivo o per un altro, versano le quattordici Fondazioni liriche italiane, tredici in base alla legge Corona del 1967 (Milano, Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Maggio musicale fiorentino) alle quali di recente si è aggiunta l’Accademia nazionale di S. Cecilia.
Se Molière una volta disse che “tra le tante seccature che l’uomo ha inventato, l’opera è la più costosa”, qualche motivo l’avrà pure avuto. E questo quattro secoli prima di poter valutare la drammatica situazione in cui, per un motivo o per un altro, versano le quattordici Fondazioni liriche italiane, tredici in base alla legge Corona del 1967 (Milano, Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Maggio musicale fiorentino) alle quali di recente si è aggiunta l’Accademia nazionale di S. Cecilia. Tanto che è storia di pochi giorni fa l’ammissione dello stesso ministro della cultura Franceschini che dopo aver avallato il licenziamento dell’intera compagine musicale dell’Opera di Roma (coro e orchestra), un fatto senza precedenti che potrebbe aprire la strada ad altre decisioni analoghe, ha ammesso che le Fondazioni “sono troppe per quello che può permettersi il Paese” e che “esiste un problema di giustizia ed equilibrio delle risorse che va affrontato". Se oltre ad affrontare il problema riuscisse anche a risolverlo sarebbe un vero e proprio miracolo sul quale però non è lecito fare affidamento.
L’impresa, infatti, è veramente titanica e parte da un presupposto inconfutabile: soltanto con gli incassi, l’opera non si può mantenere. Secondo un’inchiesta dell’anno scorso, nell’ultimo decennio i teatri lirici avrebbero accumulato debiti per 328 milioni di euro, e il trend è in crescita. Aveva provato a dare una sterzata Walter Veltroni nel 1996, quando era ministro della Cultura, con un decreto che cambiò lo stato giuridico di questi teatri trasformando gli enti pubblici in Fondazioni, una scelta che negli intenti voleva aprire la strada ad una sorta di co-finanziamento tra pubblico e privato. Peccato però che contestualmente non siano stati concessi benefici finanziari per attirare chi avrebbe voluto (o potuto) mettere denaro per sovvenzionare la lirica.
Negli Stati Uniti chi investe nei teatri (ma più in generale nella cultura) gode di forti agevolazioni e detrazioni fiscali, se in Italia si adottasse un metodo simile certo non si risolverebbe il problema ma in qualche modo eventuali sponsor sarebbero maggiormente invogliati a intervenire. A questo vanno aggiunti deficit gestionali che hanno influito pesantemente sui bilanci: tanto per fare un esempio che ci riguarda da vicino, il passivo del Carlo Felice per il 2013 è di 5,8 milioni di euro anche se si arriva da due anni di contratti di solidarietà per i dipendenti che evidentemente non sono serviti o sono serviti a pochissimo.
Così, lentamente, anno dopo anno, le Fondazioni sono diventate una specie di colabrodo che – anche queste sono parole del ministro Franceschini – “assorbono il 77% degli interventi dello Stato a favore della musica e il 47% del Fondo unico per lo spettacolo”. E altri 125 milioni sono stati stanziati per risanare quelle strutture che stavano per fallire. Nel 2013 la quota di Fus destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche è stata di 183 milioni di euro, oltre dieci in meno rispetto al 2012 (per il 2014 il Carlo Felice a fronte dei 9,3 milioni di euro dell’anno precedente ne otterrà 8,8). Così si lavora di accetta, tagliando quel che si può anche se le spese restano le stesse, a partire dai costi di gestione che ne rappresentano il 70%.
Se vogliamo parlare in termini di stipendi, in totale i dipendenti delle 14 Fondazioni italiane sono circa seimila (a Genova poco meno di 300) tra amministrativi e artisti, con una decisa disparità a favore dei primi: dal momento che ci sono spese fisse e soldi che comunque occorre spendere che si alzi o meno il sipario, questo in teoria dovrebbe portare ad aumentare il più possibile le proposte in cartellone e invece – con qualche rara eccezione - si segue la linea diametralmente opposta e i teatri spesso restano chiusi. Insomma, non si tagliano le spese ma la produzione, tanto che l’Italia, che pure è la patria del ‘belcanto’, è nel mondo solo in quinta posizione per numero di recite annuali dietro Germania, Stati Uniti, Austria e Francia nonostante il 75% delle opere in giro per il mondo parlino la nostra lingua e tra i compositori rappresentati ci siano Verdi al primo posto, Puccini al terzo e Rossini al quinto.
C’è poi tutta una serie di privilegi di cui godono molti lavoratori del settore, del tutto anacronistici nella situazione economica che viviamo da anni e alcuni veramente surreali, che pure incidono. Ricordarli non fa male: all’Arena di Verona, ad esempio, per le rappresentazioni che richiedono l’impiego di spade finte (tipo ‘Aida’ o ‘Trovatore’) è prevista un’indennità ‘armi’, come altre indennità – sempre a Verona - riguardano la lingua per le rappresentazioni di opere non in italiano o perfino il fatto di lavorare all’aperto. Sempre per quello che riguarda l’indennità ‘lingua’, al San Carlo di Napoli per farla scattare basta una sola parola straniera. Al Teatro dell’Opera di Roma è prevista un’indennità ‘Caracalla’ di cui gode anche chi alle Terme di Caracalla non ha mai lavorato e mai ci lavora.
Situazioni che forse non tutti conoscono mentre invece è balzato all’onore delle cronache quanto accaduto alla Scala nel dicembre 2012 quando si scioperò impedendo la rappresentazione del ‘Romeo et Juliette’ che inaugurava la stagione del Corpo di ballo. Il motivo? Il rifiuto di andare in scena dei ballerini che chiedevano un’indennità del 10% perché il palcoscenico era in lieve pendenza e a loro dire rischiavano un’infiammazione delle caviglie e quello del coro che pretendeva un’indennità ‘piegamenti’ perché a tratti occorreva accompagnare la musica con una inclinazione della testa. E poi ci sono ancora l’indennità di ‘cornetta’ per i suonatori di questo strumento (forse perché è uno dei pochi che ha bisogno di uno studio particolare anche per un trombettista), quella di ‘frac’, quella di ‘umidità’ e via dicendo…. Al Fellini di ‘Prova d’orchestra’ fischieranno le orecchie ed è chiaro che così non si va da nessuna parte.
In questo contesto, per venire ai fatti di casa nostra, la situazione del Carlo Felice non è dunque dissimile da quella dei suoi confratelli, tanto più che è nato con un irrimediabile peccato originale: costruito in tempi in cui non si badava a spese e si ragionava in termini di grandeur per far rinascere un teatro distrutto dalle bombe della seconda guerra mondiale e farlo diventare un fiore all’occhiello, è assolutamente sovradimensionato rispetto ad una città come Genova alla quale tutto sommato il vecchio ‘Margherita’ calzava a pennello. Facciamo due conti: costa 20 milioni l’anno mentre le entrate sono rappresentate dai 9 milioni del Fus (anzi, dal 2014 un po’ meno, come abbiamo visto prima), dai circa 2,4 che gli versa il Comune, dal milione che gli dà la Regione e dai 3 dello sbigliettamento (tanto per stare larghi, non si è mai andati sopra a questa cifra, spesso invece se ne è rimasti al di sotto).
Se la matematica non è un’opinione, questo vuol dire che il teatro accumula ogni anno un passivo di più di quattro milioni. A prescindere, direbbe Totò. Costi importanti soprattutto se si pensa che il bacino d’utenza è davvero limitato perché quando arriva qualche sparuto pullman dal basso Piemonte è già grasso che cola, ma dev’essere Piemonte davvero basso se no i melomani preferiscono ovviamente fare rotta verso il Regio di Torino. Né hanno inciso positivamente una pace sociale che nella continuità manca sostanzialmente dai tempi di Escobar (lui compreso) né i commissariamenti per i quali peraltro è in buona compagnia, vedi – nel corso di questi ultimi anni, anche se per motivi differenti – il Teatro dell’Opera di Roma, il Maggio musicale fiorentino, il ‘Petruzzelli’ di Bari e il ‘Massimo’ di Palermo.
Dunque mal comune, mezzo gaudio? Ovviamente no, ma trovare una soluzione generale al problema, prima di sprofondare definitivamente in un abisso nel quale sarà impossibile potersi specchiare senza provare vergogna, sembra davvero difficile e se mai ci si riuscirà occorreranno anni e un radicale cambiamento di impostazione, metodo e mentalità da parte di tutti. L’unica cosa sufficientemente chiara è che certezze non ce ne sono. Tranne una: Molière aveva ragione.
 15° C
15° C LIVE
LIVE

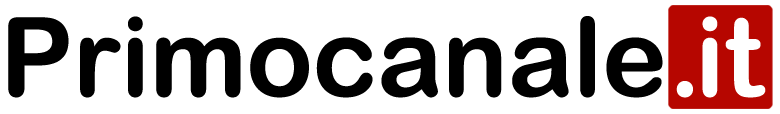
IL COMMENTO
-
Luigi Leone
Lunedì 31 Marzo 2025
-
Mario Paternostro
Domenica 30 Marzo 2025
leggi tutti i commentiLa Costituzione, Salis in Lottomatica e la politica di cui non puoi fidarti
Ti ricordi Bilancia? 17 omicidi in sette mesi di terrore