 Se ne va uno dei più importanti cardinali arcivescovi che si siano seduti sulla cattedra di san Lorenzo e che ha governato la chiesa genovese in anni difficili con una sapienza intrisa di semplicità. Se ne va Dionigi Tettamanzi, scomparso dopo una lunga malattia, il cardinale che lasciò Genova per andare a governare una delle più importanti Diocesi del mondo, quella di Milano, dopo un “gigante” come Carlo Maria Martini, con un passaggio che diede alla nostra Chiesa il ruolo di grande trampolino di lancio nelle supreme gerarchie di Santa Romana Chiesa.
Se ne va uno dei più importanti cardinali arcivescovi che si siano seduti sulla cattedra di san Lorenzo e che ha governato la chiesa genovese in anni difficili con una sapienza intrisa di semplicità. Se ne va Dionigi Tettamanzi, scomparso dopo una lunga malattia, il cardinale che lasciò Genova per andare a governare una delle più importanti Diocesi del mondo, quella di Milano, dopo un “gigante” come Carlo Maria Martini, con un passaggio che diede alla nostra Chiesa il ruolo di grande trampolino di lancio nelle supreme gerarchie di Santa Romana Chiesa.Dopo di lui venne, infatti, Tarcisio Bertone, addirittura poi promosso segretario di Stato. E Tettamanzi stesso fu in corsa per diventare papa, sia nel conclave di Ratzinger, come ancor di più in quello che ha consacrato papa Francesco.
Questo era il personaggio. Questa era la sua levatura, che a Genova ha pesato forse in modo diverso da una lettura immediata, quando l'arcivescovo Dionigi era stato interpretato come un fine teologo che doveva passare di qua “per fare carriera”.
La grande forza di Dionigi Tettamanzi era di essere un intellettuale della Chiesa che riusciva a tradurre la sua profonda dottrina anche per le anime più semplici del suo gregge.
Era entrato a Genova, dopo Giovanni Canestri, il cardinale successore di Siri, con delicatezza e prudenza e si era imposto subito per una grande capacità di ascolto. Interpellava, interrogava, ascoltava molto anche i laici e poi magari quello che gli veniva spiegato lo utilizzava anche molto tempo dopo.
“Avrebbe potuto essere un gran solitario, meglio un solista della Chiesa - ricorda uno dei preti genovesi a lui più vicini, Monsignor Marco Granara - per le sue doti intellettuali e, invece, preferiva il dialogo, la partecipazione”. Tettamanzi aveva lo stesso “tocco”, la stessa capacità di sintonia con i potenti e con i semplici.
E' stato anche l'arcivescovo del G8 genovese, del tragico luglio del 2001, ed è rimasta nel suo ricordo anche quella intervista in cui raccontò di come gli tremava la mano mentre stava benedicendo la grande nave dove in porto i potenti della terra, i capi di Stato, decidevano le sorti di quel Supervertice.
Gli tremava l'aspensorio, perchè temeva quella potenza terrena a fronte della miseria dei popoli poveri, indifesi, come in una premonizione di come sarebbe sfociata quella globalizzazione che a Genova i G8 volevano in qualche modo governare.
Tettamanzi aveva, quindi, modi semplici e diretti. Non era raro che ti chiamasse al telefonino, senza nessun formalismo e esordisse presentandosi così: “Sono il suo vescovo”. con quell'accento lombardo della sua parlata.
Sarebbe volentieri restato a Genova. La “promozione” a Milano lo impensieriva, perchè sapeva bene che quella grande Diocesi rischiava di trasformarsi spesso in una passerella con il Duomo pieno, le chiese in sintonia, ma con la difficoltà di “entrare” veramente nel suo gregge, nel suo popolo, di fare quello che considerava il vero lavoro: “il missionario”.
Il suo ultimo “segno” genovese è stato una lettera pastorale sulla famiglia che è stata considerata un capolavaro. Poi il cammino verso Milano, in una specie di pellegrinaggio di avvicinamento, che era stato anche un lungo addio genovese.
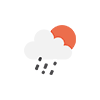 15° C
15° C LIVE
LIVE


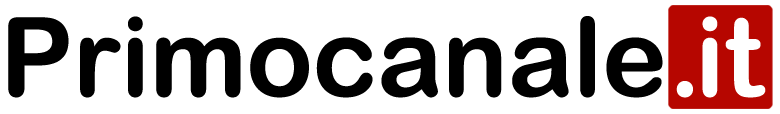
IL COMMENTO
-
Mario Paternostro
Domenica 20 Aprile 2025
-
Franco Manzitti
Sabato 19 Aprile 2025
leggi tutti i commentiLe strade dei “ragazzi partigiani” che raccontano gli eroi del 25 aprile
Ti ricordi Sergio Castellaneta, un anticipatore populista e non solo