Con grande scintillio di sorrisi, ci sono proprio tutti sulla nave della quotazione in Borsa di Fincantieri. La cui prua, in una azzeccata immagine promozionale, spunta maestosa in Piazza Affari. Oltre che un rilevante appuntamento finanziario, la cessione sul mercato azionario di circa il 45% del gruppo navalmeccanico da parte di Fintecna (che quindi rimarrà intorno al 55%, salvo l’ipotesi per ora remota di future ulteriori vendite) è anche un evento politicamente mondano. Ora sono tutti d’accordo e non c’è chi non partecipi alla crociera del successo annunciato di un collocamento che si chiuderà il prossimo 27 giugno.
In realtà, in questo Paese dalla memoria corta e dalle membra perennemente anchilosate per fare le cose quando si dovrebbe, l’attracco di Fincantieri a Palazzo Mezzanotte è la metafora delle occasioni perdute. Fra i molti che lo celebrano, tanti sono gli stessi che malcontati sette anni fa lasciarono Giuseppe Bono con il cerino in mano, da solo a sbattersi per ottenere di andare davanti agli investitori, mettersi in vendita e così trarre immediate risorse per accelerare il processo di crescita del gruppo. Bono era ed è l’amministratore delegato di Fincantieri, uno che si arrabbia se ancora lo si definisce “boiardo di Stato” – così come si chiamavano una volta, con declinazione negativa, i manager delle aziende pubbliche – ma, a dirla tutta, è anche uno che quella definizione l’ha riabilitata, soprattutto se si fa il paragone con tanti gestori della nouvelle vague, più disponibili a ragionare di stock option e arricchimenti personali che di strategie industriali fatte con i fichi secchi. Questa, infatti, è stata la parabola cui Bono s’è trovato costretto. Quando ha “osato” parlare di Borsa, ai tempi dei governi Berlusconi e Prodi, ha ottenuto apparenti sostegni dell’uno e dell’altro esecutivo, ma poi la politica e il sindacato – con in testa la Fiom Cgil e salvo qualche voce isolata levatasi dalla Uilm – hanno giocato la loro abituale partita esclusivamente incline alla cattura del facile consenso.
I partiti, che occupavano consigli d’amministrazione (c’è toccato pure di vedere il leghista Francesco Belsito assurgere alla vicepresidenza e persino ululare che Bono sarebbe stato da rimuovere) e piante organiche (inzeppate da “figli di, nipoti di, amici di” assunti ovunque lo Stato fosse il socio forte), urlarono che “no, in Borsa non si va, se non ci sono adeguate garanzie”. Lo stesso consiglio regionale ligure, con mozione d’intenti bipartisan, partorì il proprio sdegnato dissenso, sempre nel nome delle garanzie. La prima doveva essere quella del lavoro. Per carità, sacrosanto, a fermarsi a una prima, superficiale lettura. In realtà quella clausola occupazionale era una foglia di fico, che doveva coprire la vergogna di aziende – Fincantieri compresa – diventate pascolo per gli appetiti insaziabili della partitocrazia. E poi: ce li vedete degli investitori, italiani e internazionali, che mettono i loro soldi a disposizione non chi deve farli fruttare, ma di un sistema che invece tende a bruciare fino all’ultimo centesimo? Via…
Avveduto navigatore di quei perigliosi mari, però, il “boiardo” Bono ha dato scacco matto al sistema. Qualche compromesso avrà dovuto pure ingoiarlo, se è sopravvissuto a stagioni di rivolgimenti nei top management delle società di Stato, ma forte di un’immagine mai sfiorata dalla minima chiacchiera e con la caparbietà del calabrese che prende di punta le cose, ha cominciato a costruire la Fincantieri di oggi: acquisizioni qua e là per il mondo, portafoglio ordini che andava gonfiandosi, accordi sindacali che hanno rotto gli schemi e accresciuto il livello della produttività anche in quegli stabilimenti italiani che sono da sempre croce (troppe rigidità) e delizia (elevato tasso di qualità professionale) del gruppo. Privato delle risorse che gli sarebbero arrivate dalla Borsa, Bono ha sfruttato la dote italica della fantasia, inventandosi una politica industriale della quale governi di colore diverso non sono stati capaci, ma che hanno creato denaro all’interno e di conseguenza rafforzato il timoniere di Fincantieri e tutta la sua struttura. Mettendoli nella condizione che nessuno osasse più fiatare (la continuità gestionale si sta rivelando, anzi, la prima plusvalenza che va all’incasso) quando sono tornati a parlare di Borsa. Anzi, loro si sono limitati a sussurrarne. Sono stati prima Enrico Letta e poi Matteo Renzi ad accorgersi che avevano lì, in casa, un gioiello dal quale poter ricavare, subito, credibilità internazionale in tema di privatizzazioni e, in futuro (ma non per i prossimi tre anni), dividendi con cui dare respiro alle asfittiche casse dello Stato.
Il quesito, però, è: come sarebbero andate le cose se Fincantieri fosse stata quotata quando Bono lo chiese la prima volta? La storia non si può riscrivere e, dunque, per qualsiasi risposta manca la controprova. Resta il dubbio, tuttavia, che il gruppo sarebbe oggi più solido di quanto già non sia. Perché avrebbe avuto maggiori risorse per attraversare una fase di competizione globale ai limiti del selvaggio - con le aziende del Far East, tanto per dire, a fare dumping - e perché nessuno può dimostrare che il management non avrebbe saputo dispiegare le stesse energie, ottenendo i medesimi risultati, se avesse goduto di condizioni migliori, anziché dover fare di necessità virtù. Per la navalmeccanica italiana, sette anni che la politica ha fatto gettare al vento. E giusto per non farsi mancare niente, Genova ulteriormente partecipa: con il ribaltamento a mare dello stabilimento di Sestri Ponente che subisce l’ennesimo rinvio. Complimenti.
economia
L’EDITORIALE/ Fincantieri in Borsa, il Paese delle occasioni perdute
4 minuti e 46 secondi di lettura
Ultime notizie
- Sampdoria: fiducia a tempo per Semplici. Ma Pirlo resta sullo sfondo
- Cantieri e incidenti, rientro da incubo sulle autostrade della Liguria
- Escursionista si fa male a Monesteroli, salvata con l'elicottero
-
Palazzo Ducale, successo per 'La Storia in Piazza': in 15 mila agli eventi
-
Francesco Baccini ai Portofino Days: “La mia musica per Genoa e Boca"
-
Al Portofino Days il docufilm su Pino Daniele. Il produttore Senardi: “Un artista immenso”
 14° C
14° C LIVE
LIVE

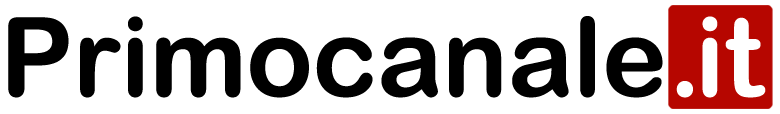
IL COMMENTO
-
Mario Paternostro
Domenica 30 Marzo 2025
-
Franco Manzitti
Sabato 29 Marzo 2025
leggi tutti i commentiTi ricordi Bilancia? 17 omicidi in sette mesi di terrore
Partito del no, del si e magari del ni. Uffa che barba di campagna elettorale