 Con il referendum costituzionale che si svolgerà in autunno si va a votare a favore o contro la riforma Boschi-Renzi. Perché votare Sì e perché votare No? Proseguiamo il dibattito con l'intervento di Mara Carocci, deputata del Partito Democratico.
Con il referendum costituzionale che si svolgerà in autunno si va a votare a favore o contro la riforma Boschi-Renzi. Perché votare Sì e perché votare No? Proseguiamo il dibattito con l'intervento di Mara Carocci, deputata del Partito Democratico. Gentile direttore, nel rispondere al vostro invito al dibattito sul referendum costituzionale, sceglierò solo uno fra i motivi per i quali voterò sì al Referendum perché mi pare particolarmente significativo: l’iter legislativo.
L’esistenza di problemi reali è segnalato dal fatto che da trent’anni si discuta di riforma costituzionale, purtroppo senza esito nonostante siano state ad essa dedicate ben tre Commissioni bicamerali: la Bozzi (1983-1985), la De Mita-Iotti (1992-1994), la bicamerale D’Alema (1997-1998 ).
Perché cambiare? Qual è la situazione attuale? Succede che i tempi della politica non corrispondono ai tempi della vita delle persone, ai tempi che dovrebbe avere la soluzione dei loro problemi. Il bicameralismo paritario rende particolarmente lunga e difficile l’approvazione delle leggi, che fanno la spola anche più volte fra Senato e Camera. Se la politica non riesce a collegare i propri tempi con quelli della società diventa inutile.
Ecco alcuni esempi di leggi da tempo bloccate al Senato nel “ping pong” attuale tra le due Camere: Contrasto dell’omofobia e della transfobia (ferma da 1143 giorni), Nuovo codice della strada (1122 giorni), Nuove norme sulla cittadinanza, Reato di tortura (esame iniziato tre anni fa al Senato, ora fermo a palazzo Madama dopo le modifiche introdotte a Montecitorio), Riforma della protezione civile (che prevede misure sulla prevenzione, fra le quali la revisione e valutazione periodica dei piani di emergenza comunali). Per non parlare delle leggi che non concludono l’iter e transitano da una legislatura all’altra per anni.
Una democrazia che non riesce a decidere non è una democrazia compiuta. Una sola Camera che approva la maggior parte delle leggi permetterà un percorso legislativo molto più breve e la possibilità di approvare le leggi quando servono. Nella riforma sono previsti strumenti di garanzia: il Senato potrà chiedere di esaminare le leggi approvate dalla Camera, ma dovrà farlo entro 40 giorni, e deciderà assieme alla Camera sulle leggi costituzionali ed elettorali, i referendum popolari, e ancora sulle leggi sugli organi di governo, sulle funzioni di Comuni e città metropolitane e sull’Unione europea.
Inoltre, succede adesso che vengano discusse ed approvate soprattutto, se non quasi esclusivamente, leggi proposte dal Governo, poche di iniziativa parlamentare, nessuna di iniziativa popolare. E per accelerare l’iter di quelle che considera importanti il Governo pone spesso la questione di fiducia.
A giugno 2016, per fornire qualche dato, i disegni di legge approvati da una Camera ed in corso di esame nell’altra erano 58 al Senato e 28 alla Camera (82 in totale). Delle leggi approvate 165 sono state di iniziativa governativa (82,50%), 33 di iniziativa parlamentare (16,50%), 2 di iniziativa mista (1%). A queste si aggiungono 220 decreti, ovviamente sempre del Governo: è evidente la sproporzione a favore del Governo.
Nella Riforma il voto a data certa dà tempi di attuazione definiti per disegni di legge ritenuti prioritari dal governo, e questo limiterà il ricorso alla fiducia, e si introducono limiti alla decretazione di urgenza, che prima erano presenti sì, ma solo in legge, mentre adesso entrano nella Costituzione. Si garantisce inoltre l’esame e la deliberazione finale sulle leggi di iniziativa popolare.
Si ridà quindi centralità al Parlamento ed ai cittadini, la cui partecipazione è ampliata dalla modifica del quorum per il referendum abrogativo e dall’introduzione dei referendum propositivi e di indirizzo. Si mantengono quindi le fondamentali garanzie costituzionali, rafforzando – se mai – la centralità del Parlamento ed alcuni istituti di partecipazione: iniziativa legislativa, referendum popolari, possibilità di vaglio preventivo della Corte costituzionale per le leggi elettorali.
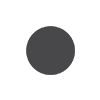 13° C
13° C LIVE
LIVE

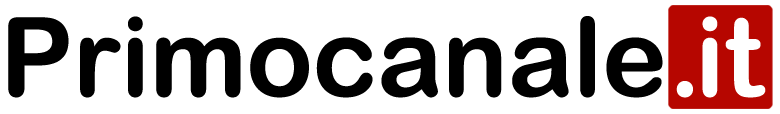
IL COMMENTO
-
Mario Paternostro
Domenica 06 Aprile 2025
-
Franco Manzitti
Sabato 05 Aprile 2025
leggi tutti i commenti"Ti ricordi Bilancia?" 17 vittime scelte per odio e per caso
Che brutta quella piazza cerniera che doveva salvare il centro storico