Donya, vent’anni, è un’afghana sfollata dal suo paese che abita a Fremont, in California, vicino alla Silicon Valley, dove vive e lavora la più grande comunità del suo paese negli Stati Uniti da quando i talebani sono saliti al potere. Al medico da cui va per curare l’insonnia confessa di non passare molto tempo a pensare perché troppo impegnata con la sua vita sociale. Peccato che la sua vita sociale sia totalmente inesistente. Ex traduttrice dell'esercito americano che è fuggita dall'Afghanistan lasciando la famiglia per paura della rappresaglia dei talebani avendo lavorato a favore del nemico e in quest’ottica tradito il proprio paese, è tormentata da pensieri e sensi di colpa che sono parte del motivo per cui non riesce a dormire. È una straniera in terra straniera e sebbene parli fluentemente inglese, abbia un lavoro e viva in questa comunità di connazionali è sostanzialmente sola, tormentata dal passato.
Qualcuno attorno ce l’ha: due vicini continuamente persi in discorsi filosofici; un cameriere del ristorante che frequenta che cerca di nascondere un’eccessiva affinità per le soap opera turche; il terapeuta che si affida un po' troppo a ‘Zanna bianca’ di Jack London per aiutare ad alleviare la sua irrequietezza e i datori di lavoro, una gentile coppia cinese proprietaria di una fabbrica di biscotti della fortuna. Quando viene promossa dall'incartarli a scrivere i messaggi che contengono all’interno, nella speranza di incontrare un uomo mette il suo numero di telefono in un biscotto. Finirà per imbattersi in un timido meccanico con cui dà vita ad una tenera relazione che influenzerà fortemente la sua vita.

‘Fremont’ di Babak Jalali, regista inglese di origine iraniana, è un film delicatamente malinconico, dolcemente solitario e sottilmente spiritoso. Un piccolo poema sui dolori dell'essere sfollati, sulle ferite della nostalgia di casa e sul nostro desiderio di sfuggire alle notti inquiete della solitudine reso con delicatezza e autenticità emotiva. Girato in bianco e nero e realizzato con empatia e umorismo è una commedia che riporta a certe atmosfere scarne e ironiche dei film di Jarmush o Kaurismaki: mai sdolcinato e più profondo di quanto non sembri a prima vista nelle sue considerazioni sull'isolamento umano. E’ buffo, se vogliamo anche furbo, e trova umorismo nell’oscurità che circonda la protagonista, nel suo sguardo risoluto che è quello di chi sa e osserva sempre più di quanto ammetta.
Questo ritratto di un'immigrata che si vieta di sognare e cerca di trovare il proprio posto in un mondo che non sente suo gioca sulla semplicità e su una malinconia estremamente poetica mostrandoci anche quanto possa essere in realtà poco degno di nota il sogno americano e come non sia il fine ultimo per gli immigrati come si vuol far credere. L'America che vediamo qui è una terra di anime sole, di rifugiati che si sentono in colpa per aver voltato le spalle alle proprie radici: single della classe operaia in cerca di felicità, meccanici malinconici e terapisti in lacrime che si curano da soli. Nella città di Fremont queste persone si incontrano, interagiscono, socializzano e tuttavia si ritrovano sole.
Ma se l’America come la conosciamo non è più il luogo in cui i sogni diventano realtà e le possibilità sono infinite, per Babak Jalali è ancora un luogo in cui le persone possono sfuggire alle loro vecchie vite e provare a ricominciare da capo. Certo, il ritmo lento della narrazione richiede pazienza ma è un film che colpisce per la sua leggerezza e la sua decisione di essere piccolo e intimo trovando il romanticismo nelle interazioni quotidiane e nel facile piacere di aprire un biscotto e leggere lì dentro la propria fortuna.
 13° C
13° C LIVE
LIVE

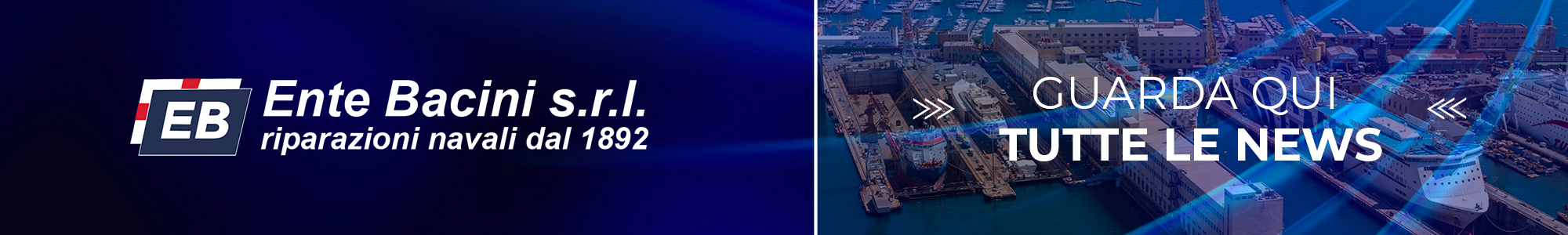


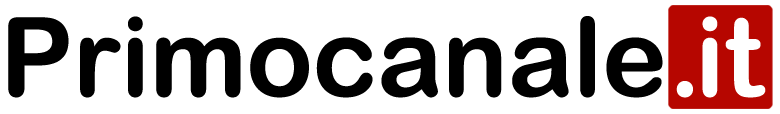
IL COMMENTO
-
Carlo Buttaroni*
Giovedì 03 Aprile 2025
-
Luigi Leone
Lunedì 31 Marzo 2025
leggi tutti i commentiLa scienza dei sondaggi: ecco come lavoriamo per raccontare la realtà insieme a Primocanale
La Costituzione, Salis in Lottomatica e la politica di cui non puoi fidarti