 Territorialità e difesa degli azionisti. Anche passando attraverso l’aggregazione con un’altra banca. E’ il mantra che sale dalla Fondazione e dalla politica, che nella Fondazione sguazza ancora, per contrastare l’aumento di capitale da 500-650 milioni previsto da Carige per mettersi in linea con le prescrizioni della Bce sulla patrimonializzazione dopo la bocciatura agli stress test. L’argomento arriva domani nel consiglio della banca, chiamato a rispondere all’ente guidato da Paolo Momigliano che, la settimana scorsa, attraverso una lettera ha formulato una serie di domande-contestazioni. Gli argomenti sono quelli ricorsi con frequenza nelle polemiche di questi giorni: perché non si è valutato se cedere parte della rete degli sportelli?; quando e come è stato definito il coinvolgimento di Mediobanca?; perché non si è valutata l’ipotesi di una aggregazione?
Territorialità e difesa degli azionisti. Anche passando attraverso l’aggregazione con un’altra banca. E’ il mantra che sale dalla Fondazione e dalla politica, che nella Fondazione sguazza ancora, per contrastare l’aumento di capitale da 500-650 milioni previsto da Carige per mettersi in linea con le prescrizioni della Bce sulla patrimonializzazione dopo la bocciatura agli stress test. L’argomento arriva domani nel consiglio della banca, chiamato a rispondere all’ente guidato da Paolo Momigliano che, la settimana scorsa, attraverso una lettera ha formulato una serie di domande-contestazioni. Gli argomenti sono quelli ricorsi con frequenza nelle polemiche di questi giorni: perché non si è valutato se cedere parte della rete degli sportelli?; quando e come è stato definito il coinvolgimento di Mediobanca?; perché non si è valutata l’ipotesi di una aggregazione?La Fondazione, insomma, mette pesantemente in dubbio l’azione portata avanti dal presidente della banca Cesare Castelbarco Albani e dall’amministratore delegato Piero Montani. E però: le alternative ipotizzate sono percorribili? La Bce, che dallo scorso 4 novembre ha assunto la vigilanza dei principali istituti di credito italiani, fra cui Carige, in realtà fissa un percorso di adeguamento che è abbastanza rigido: in primis la ricapitalizzazione e poi, ma per una quota residuale, l’eventuale cessione di asset. Il tutto secondo un piano che andrà comunicato entro lunedì’ prossimo e quindi portato a compimento entro il prossimo mese di giugno.
Ogni altra opzione è al momento da escludersi. Piaccia o no è la linea dettata dall’Eurotower, che peraltro a ben vedere non è così balzana. Se la banca ha un problema i primi a dover provvedere pro-quota sono i proprietari, cioè i soci. Il cui esborso varia in ragione della volontà e della disponibilità finanziaria. Semplice e lineare. Che cosa succede, allora? La Fondazione la volontà ce l’avrebbe, ma non disponendo del denaro necessario prova a difendere la propria presa sul suo cespite bancario anche a costo di ridimensionarlo. Vedi alla voce cessione di sportelli, che significa intaccare le prospettive di crescita, mettere in discussione una parte dei livelli occupazionali e ridurre la presenza sul territorio.
Ma la territorialità non è un bene da difendere, secondo Momigliano e i sodali della Regione Liguria, con in prima linea il governatore Claudio Burlando e la delfina Raffaella Paita? La contraddizione è evidente e spiega l’irritazione delle sigle sindacali che sabato scorso hanno sparato alzo zero proprio sulla Fondazione, il cui atteggiamento, secondo i sindacati, rischia di vanificare “i sacrifici dei lavoratori”. Il tema della territorialità torna anche su un’altra ipotesi di lavoro messa in campo dall’ente con la benedizione dell’accoppiata Burlando-Paita: l’aggregazione con una banca che faccia da “cavaliere bianco”, come si dice in gergo. Le tecnicalità di una simile operazione sono quasi impossibili alla luce dei tempi concessi per rispettare le prescrizioni della Bce, ma soprattutto l’indicazione che arriva da Francoforte – e dalla stessa Bankitalia – è quella di prevedere solo in un secondo tempo, cioè a riallineamento compiuto con la ricapitalizzazione (più la vendita di asset per una quota marginale). Anche qui, l’atteggiamento è lineare: l’aggregazione deve avvenire fra banche in condizioni ottimali, nella prospettiva di creare un nuovo soggetto forte, non nell’ottica di diluire le debolezze di una banca (meglio: di un azionista di controllo alla canna del gas) in una nuova compagine che finirebbe per intaccare anche la solidità del partner.
Per un momento, tuttavia, facciamo finta che nulla di tutto questo circondi il complicato dossier. Come si può pensare che la “liguritudine” di Carige verrebbe preservata dal matrimonio con un istituto oggi inevitabilmente più forte, in particolare nel suo azionariato? Pure in tal caso, la contraddizione delle argomentazioni messe in campo da Fondazione e Regione Liguria risulta tanto evidente quanto l’imperizia o la strumentalità nell’affrontare la questione. La prima potremmo archiviarla alla voce per cui “un bel tacer non fu mai scritto”, ma in realtà ad animare certi interventi sembra piuttosto la seconda. Risulta abbastanza evidente che a temere l’azione portata avanti da Castelbarco e Montani sia certa politica, che in Carige, ai tempi di Giovanni Berneschi, ha visto il bancomat attraverso cui finanziare operazioni come gli Erzelli, il mutuo all’istituto Arte per fargli comprare gli immobili sanitari della Regione (e cercare di tappare la falla di bilancio, anche se la Corte dei Conti ha poi detto che si poteva fare) o i prestiti “facili” a imprenditori spesso trovatisi nella doppia di veste di azionisti e debitori della banca. La Fondazione è figlia di questa politica, perché nel consiglio d’amministrazione e in quello di indirizzo dell’ente siedono i designati di un sistema di potere che tuttora fa capo al governatore Burlando, all’ex ministro Claudio Scajola e allo stesso Berneschi, con gli ultimi due certo in grado di incidere molto meno che in passato.
Ma siccome le cose non vengono chiamate con il loro nome, questa politica ulula anche alla difesa dei piccoli azionisti, mascherando con una buona dose di populismo l’obiettivo di difendere l’azionista che davvero sta a cuore, cioè la Fondazione. Per sostenere meglio la tesi si sovrappone la figura dei piccoli azionisti con quella dei risparmiatori. Il che in molti, moltissimi casi è pur vero. E però: chi oggi non sa che scegliere la Borsa è uno dei modi peggiori per avere la garanzia del capitale iniziale, da una parte farà bene a prendere per la cravatta il proprio consulente finanziario (sia essa la stessa Carige, per rimanere in tema) e dall’altra dovrà compiere un sano esercizio di autocritica. Se, poi, ci si fa attrarre dalla possibilità di fare dei guadagni che altri strumenti più sicuri non possono dare, allora si accetti il rischio e non si recrimini se le cose non vanno come sperato.
Insomma, l’argomento dei piccoli azionisti-risparmiatori è specioso. E discutibile è la rimostranza della Fondazione sul fatto che lo stesso giorno dell’annuncio della bocciatura agli stress test il vertice di Carige abbia subito parlato di ricapitalizzazione garantita da Mediobanca. Sarebbe stato preoccupante se Castelbarco e Montani non avessero chiara la percezione di come sarebbero potute andare le cose in Bce e ancor più avrebbe dovuto allarmare se non si fossero preparati all’evenienza. Sebbene alcuni rumor dicano il contrario, il fatto che la Fondazione ponga il quesito fa supporre che non fosse informata e se così stanno le cose il management ha peccato come minimo di eleganza. A ben vedere, però, inquieta anche che non sia stato lo stesso principale azionista a prevenire lo scenario peggiore, sollecitando il management della banca ad agire in via preventiva (magari suggerendo di scartare Mediobanca, se proprio Piazzetta Cuccia non piace). Forse è accaduto proprio perché di ricapitalizzazione la Fondazione non voleva e non vuol sentir parlare. Più incline, invece, a ripercorrere la strada, accompagnata da certa politica, che a lungo ha contraddistinto il capitalismo familiare italiano. Che con pochi spiccioli, all’epoca dei cosiddetti “nocciolini duri”, controllava colossi come Telecom Italia. Per la serie: tu ci metti i soldi e io comando. Non funziona più così.
 18° C
18° C LIVE
LIVE

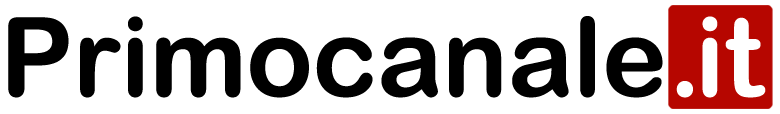
IL COMMENTO
-
Franco Manzitti
Sabato 05 Aprile 2025
-
Carlo Buttaroni*
Giovedì 03 Aprile 2025
leggi tutti i commentiChe brutta quella piazza cerniera che doveva salvare il centro storico
La scienza dei sondaggi: ecco come lavoriamo per raccontare la realtà insieme a Primocanale