 Le dimissioni di un Capo dello Stato sono di per se stesse evento che chiama all’esercizio del giudicare un esercito di politologi, giornalisti, politici, economisti, psicologi e chi più ne ha più ne metta. E’ un palcoscenico, al quale nessuno vuole sottrarsi e al quale, anzi, si spintona per accedere. Per dire che cosa, poi? Ecco il punto. Se ne sono scritte e sentite “di ogni”, senza ad alcuno venisse il soprassalto di un dubbio: abbiamo tutti gli elementi per esprimere un giudizio compiuto sul “novennato” di Giorgio Napolitano?
Le dimissioni di un Capo dello Stato sono di per se stesse evento che chiama all’esercizio del giudicare un esercito di politologi, giornalisti, politici, economisti, psicologi e chi più ne ha più ne metta. E’ un palcoscenico, al quale nessuno vuole sottrarsi e al quale, anzi, si spintona per accedere. Per dire che cosa, poi? Ecco il punto. Se ne sono scritte e sentite “di ogni”, senza ad alcuno venisse il soprassalto di un dubbio: abbiamo tutti gli elementi per esprimere un giudizio compiuto sul “novennato” di Giorgio Napolitano? A me questo dubbio è venuto, la domanda me la sono posta e marzullianamente mi sono anche risposto: no che non li abbiamo, tutti gli elementi. Qualsiasi valutazione si faccia oggi può essere solo parziale. Giudicare una personalità forte e complessa come quella di Re Giorgio con la lente di ingrandimento della cronaca politica comporta un esito distorto, figlio della partigianeria del momento. Il che motiva la discordanza di opinioni, positive o negative che siano, soprattutto quando emergono dal parterre dei partiti. Le motiva, non le giustifica.
Prendiamo il caso di chi contesta a Napolitano la pervicacia con cui ha perseguito, variamente declinata, la pratica delle larghe intese. Stupirsene, però, significa averlo votato una prima e una seconda volta senza avere la minima consapevolezza semplicemente della storia personale di Napolitano. E’ un “dialogante” nel dna, perché tale era ai tempi del Pci, quando non casualmente fu il primo leader del partito a sbarcare negli Stati Uniti (ancora gli Usa negavano il visto ai comunisti) e quando venne accusato di essere troppo favorevole al compromesso storico o di guardare con eccessivo interesse al Psi di Bettino Craxi. Se tale era Napolitano in quegli anni difficili, perché ritenere che potesse essere diverso in quelli, non meno complicati, che ha attraversato durante la sua permanenza al Quirinale? C’è stato un difetto, nelle valutazioni dei partiti: giudicare un personaggio rimasto fedele a se stesso con il metro del loro comportamento, incoerente nei fatti e non soltanto per definizione denigratoria. Ma neppure quel marchio d'origine, "dialogante", basta a spiegare quanto avvenuto. C'è sicuramente di più e questo di più è ancora da svelare.
Invece, in questo gioco di tirare l’acqua al proprio mulino è dilagata anche la polemica per il “colpo di Stato” che Napolitano avrebbe perpetrato sulla caduta del governo Berlusconi, nell’autunno del 2011. Un’accusa imperniata sul fatto che Re Giorgio non sciolse le Camere, ma affidò l’esecutivo a Mario Monti, dopo averlo consultato ben prima che l’ex Cavaliere facesse un passo indietro. La spiegazione sotto gli occhi di tutti è che la crisi economico-finanziaria era tale (con lo spread fra i Btp italiani e i Bund tedeschi a livelli insopportabili) da sconsigliare il ricorso alle urne.
Probabilmente è vero, ma fermarsi a ciò e bollare quella mossa come sbagliata, o per converso giusta, rischia di essere limitativo, cioè di giudicare solo l’effetto senza andare alla causa vera che lo ha prodotto. Non ci si può esimere, in realtà, dal porsi una domanda: fu solo un problema di spread, o intervennero anche altri fattori, in ambito nazionale ed europeo, a spingere Napolitano su quella strada? Finora le risposte sono state figlie di pura dietrologia, interpretativa di circostanze, segnali, indicazioni o rivelazioni che hanno un difetto di fabbrica: nulla di suffragato da qualcosa di concreto. Come si fa, però, a esprimere un giudizio compiuto finché non si apriranno i cassetti, scoprendo se esistono degli atti precisi o se, invece, sono vuoti? Fino a quel momento, qualsiasi valutazione rimane sospesa. Ed è fatalmente parziale.
Alla fine, dunque, bisogna arrendersi all’evidenza. Nove anni così intensi, lastricati di decisioni che Napolitano ha adottato o sollecitato come garante della Costituzione, ma interpretando nel modo più pieno il mandato presidenziale, possono avere un solo giudice. La storia. Possibilmente scritta né dai vincitori né dai vinti.
 15° C
15° C LIVE
LIVE

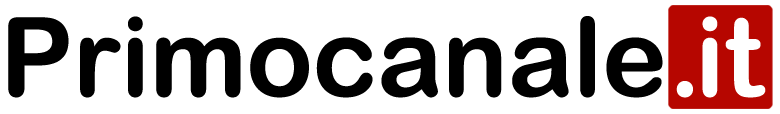
IL COMMENTO
-
Luigi Leone
Lunedì 07 Aprile 2025
-
Mario Paternostro
Domenica 06 Aprile 2025
leggi tutti i commentiDai dazi di Trump al voto per Genova, quando il mondo va alla rovescia
"Ti ricordi Bilancia?" 17 vittime scelte per odio e per caso