 La sharing economy offre vecchi servizi in modo innovativo. In più smuove le acque in settori tradizionalmente molto regolamentati e immuni dalla concorrenza. Tuttavia, lo fa al prezzo di cambiare le relazioni industriali. Il confine rotto tra lavoratori dipendenti, free-lance e occasionali.
La sharing economy offre vecchi servizi in modo innovativo. In più smuove le acque in settori tradizionalmente molto regolamentati e immuni dalla concorrenza. Tuttavia, lo fa al prezzo di cambiare le relazioni industriali. Il confine rotto tra lavoratori dipendenti, free-lance e occasionali.COS’È LA SHARING ECONOMY - Poche invenzioni nell’economia dei servizi hanno provocato un acceso e intenso dibattito come Uber, il servizio di trasporto automobilistico privato che attraverso un’applicazione software mobile mette in collegamento diretto passeggeri e autisti. Ma Uber rappresenta davvero un’innovazione? (Qui ci riferiamo in particolare a Uberpop, ovvero il servizio basato su autisti non professionisti).
Uber è il più famoso esempio della cosiddetta sharing economy. La premessa è semplice: gli individui hanno competenze, i clienti cercano servizi abbordabili, e la Silicon Valley li mette in contatto permettendo ad asset fisici di essere disaggregati e consumati come servizi. In questo modo, le relazioni capitalistiche si muovono verso un’efficiente struttura peer-to-peer (tra pari).
Gli individui possono così aggirare le rigidità di alcuni servizi tradizionali, riducendo i costi delle transazioni grazie alla tecnologia o traendo profitto da asset sottoutilizzati. Così come altre innovazioni scaturite dalla rivoluzione digitale, Uber nasce e si sviluppa in una profonda incertezza regolamentare, ponendo difficili domande: i business peer-to-peer competono slealmente con i servizi tradizionali grazie al fatto che non pagano le stesse tasse? Quale impatto hanno questi servizi sulla privacy? I lavoratori free-lance della sharing economy sono dei micro-imprenditori o dei lavoratori micro-retribuiti che competono slealmente con altri lavoratori? Ma il punto di partenza è: c’è qualcosa di nuovo in Uber?
DOV’È LA NOVITÀ - Non è facile rispondere. Esiste senz’altro una forma di innovazione di processo nel trasformare un costoso bene di consumo (l’auto) in una fonte di profitto, introducendo oltretutto concorrenza in un settore tradizionalmente protetto e ultra-regolamentato. Immaginato su larga scala, questo processo ha anche il potenziale di trasformare i nostri stili di vita, in particolare il tradizionale rapporto che abbiamo con la proprietà e il modo in cui usiamo auto e strade.
L’efficienza dell’uso dell’automobile potrebbe migliorare, vista l’attuale attitudine a portare un passeggero per volta quando se ne potrebbero portare tre o quattro. L’abbassamento dei prezzi potrebbe però anche condurre a una diversione degli utenti dal trasporto pubblico, portando a un aumento del numero di auto per strada. Purtroppo, il beneficio netto è difficile da stimare senza un modello in cui i due fattori vengono soppesati, e difficile è anche calcolare le esternalità ambientali.
Da un altro punto di vista, si potrebbe obiettare che anche nel processo c’è ben poco di nuovo, in quanto Uber costituirebbe solo una forma di franchising. In questo modello commerciale, una parte concede all’altra l’uso del proprio marchio e dei propri processi per produrre un bene o un servizio standardizzato. Si potrebbe dunque considerare Uber come franchisor e il guidatore come franchisee.
La domanda principale relativa agli elementi di innovazione apportati da Uber riguarda proprio il ruolo di Uber in quanto intermediario. Nella relazione fra Uber e i guidatori, chi è il capitalista? L’investimento è parzialmente sostenuto da Uber (la tecnologia) e – in misura maggiore – dai guidatori. A loro spettano infatti tutti i costi relativi alla vettura (acquisto o noleggio, manutenzione, carburante, assicurazione, eccetera). Inoltre, il guidatore non può decidere il prezzo del servizio, né negoziare la porzione di ricavo a lui spettante: sono decisioni prese unilateralmente da Uber.
La sharing economy offre vecchi servizi in un modo, per alcuni aspetti, innovativo. La novità risiede nel processo, ovvero nella capacità di mobilizzare capitale sottoutilizzato e creare una nuova divisione del lavoro utilizzando una tecnologia che permette un efficiente e immediato aggiustamento tra domanda e offerta. Ciò smuove le acque in settori tradizionalmente molto regolati e immuni dalla concorrenza e di conseguenza suscita grande interesse.
Tuttavia, lo fa al prezzo di un impatto sulle relazioni industriali e rompendo i tradizionali confini tra free-lance, lavoratori dipendenti e chi offre lo stesso servizio in modo amatoriale e solo occasionalmente. La rottura dei confini rischia di implicare una progressiva riduzione dei redditi (a causa delle paghe basse nel settore) e delle entrate fiscali (non è chiaro al momento chi paga quali tasse), a meno che i sistemi non vengano opportunamente ridisegnati per colmare i vuoti di oggi. Per queste ragioni, urge orientare l’agenda della ricerca sugli effetti distributivi di questi trend.
Uber non è infatti un caso isolato, e se è improbabile che la sharing economy sostituisca interamente le tradizionali forme di commercio dei servizi, è probabile che il suo ruolo nell’economia sia destinato a crescere, con importanti effetti sui nostri modelli socio-economici di riferimento.
(Tratto da www.lavoce.info)
 13° C
13° C LIVE
LIVE

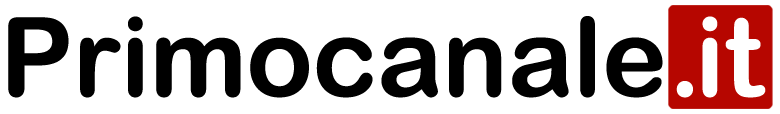
IL COMMENTO
-
Carlo Buttaroni*
Giovedì 03 Aprile 2025
-
Luigi Leone
Lunedì 31 Marzo 2025
leggi tutti i commentiLa scienza dei sondaggi: ecco come lavoriamo per raccontare la realtà insieme a Primocanale
La Costituzione, Salis in Lottomatica e la politica di cui non puoi fidarti