
Il carcere è una pena. Non l’unico tipo di pena prevista dal nostro ordinamento, ma certamente la prima a cui pensiamo, soprattutto quando si tratta di reati particolarmente odiosi. E la parola “pena” ha due diverse valenze, entrambe presenti in relazione alla detenzione: punizione e sofferenza. Sei punito, ed in questa punizione dev’essere contenuta una certa sofferenza, altrimenti non la si considera una vera punizione. Non si ricorre al carcere solo per “mettere in sicurezza” la nostra società, ma anche e forse soprattutto per punire chi infrange le regole. Se tutti i criminali fossero posti in un resort di lusso, circondato da mura invalicabili e da cui non si può sfuggire, forse saremmo tutti più sicuri ma lo troveremmo ingiusto.
Ma se la pena non mette in sicurezza la nostra società, non è altrettanto ingiusto? A cosa serve un carcere che produce maggiore criminalità, recidiva, violenza? Perché questo è oggi il sistema penitenziario italiano. I garanti territoriali delle persone private della libertà si stanno mobilitando da alcuni mesi intorno al tema dei suicidi e delle morti in carcere. Secondo Ristretti, sito di informazione curato da detenuti e operatori penitenziari, che tra l’altro cura il Dossier: "Morire di carcere" ad oggi i morti in carcere nel 2024 sono 100, di cui 44 suicidi. L’incidenza della morte per suicidio in carcere è venti o trenta volte quella che si ha all’esterno. E già quattro i suicidi anche tra gli agenti di polizia penitenziaria. Ritengo il suicidio in carcere non un dato fisiologico, a cui dobbiamo abituarci, ma la spia di un disagio profondo, risultato di un carcere che non rieduca, non garantisce sicurezza, non dà prospettive.
Secondo alcune analisi molti suicidi avvengono nelle prime settimane di carcerazione, a significare l’importanza dello choc carcerario. Altri invece quando si avvicina il fine pena. Non sarà mai sottolineata abbastanza l’importanza dell’accoglienza e di un trattamento finalizzato al reinserimento. Non si può ridurre il suicidio ad una dimensione sanitaria o psichiatrica, anche se certo il supporto di specialisti in relazioni di aiuto è fondamentale. Ma va notato che spesso gli psicologi assunti dall’amministrazione penitenziaria devono dedicare buona parte del proprio tempo a partecipare a consigli di disciplina dove si decidono le sanzioni per i detenuti che hanno infranto il regolamento piuttosto che ad azioni di supporto. Eppure potremmo leggere quelle infrazioni, soprattutto quando compiute da giovani, come un grido di aiuto, la voglia di essere visti: poco più che adolescenti, privi di figure di riferimento, fanno il proprio Edipo contro l’autorità penitenziaria non avendo spesso avuto un padre a cui ribellarsi. Un simile grido, anzi ancora più forte, lo abbiamo con i gesti di autolesionismo ed i tentati suicidi, che talvolta possono anche condurre alla morte.
Si può fare qualcosa? Sì, a partire da cose semplici: aumentare le telefonate, che sono a carico delle persone detenute; facilitare l’ingresso in carcere della comunità esterna, realizzando iniziative che vadano a riempire il vuoto dell’estate; consentire incontri intimi con il coniuge o il partner, come ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale; non introdurre nuovi reati che non danno maggior sicurezza ma servono soltanto a riempire ancor di più le carceri, come nella ventilata fattispecie della rivolta carceraria dove si potrebbe essere puniti con due anni di reclusione per resistenza passiva agli ordini. Ma anche la comunità esterna può fare molto. Ad esempio, i comuni dovrebbero consentire l’iscrizione anagrafica dei detenuti, così come previsto dalla norma di legge, anche nel caso di persone prive del permesso di soggiorno. I programmi di formazione professionale dovrebbero coinvolgere in modo continuativo la popolazione carceraria. Gli imprenditori dovrebbero investire in attività produttive da realizzare in carcere, fruendo peraltro di importanti riduzioni fiscali e contributive.
Dal carcere prima o poi si esce. Al di là della retorica del “buttiamo via la chiave” sta a noi scegliere se ci bastano punizione e sofferenza oppure se vogliamo dare un senso ad una istituzione dove vivono 61.547 persone, in spazi che potrebbero ospitarne al massimo 50.000, senza contare le migliaia di uomini e donne che ci lavorano, a partire dalla polizia penitenziaria.
Doriano Saracino
Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
 14° C
14° C LIVE
LIVE
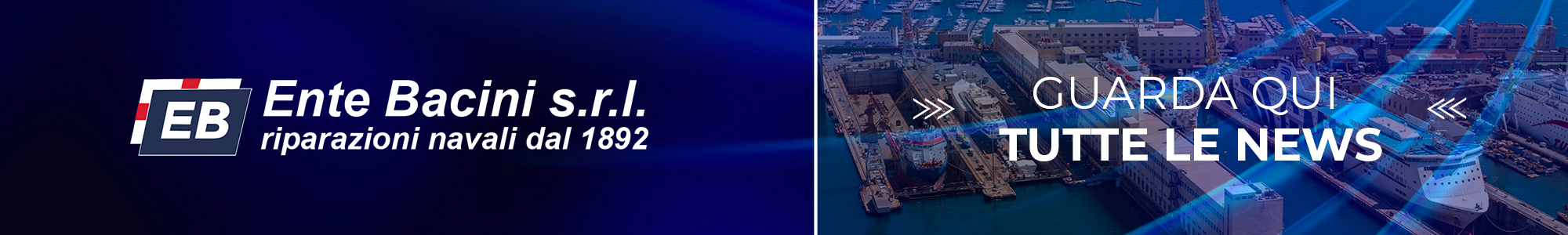

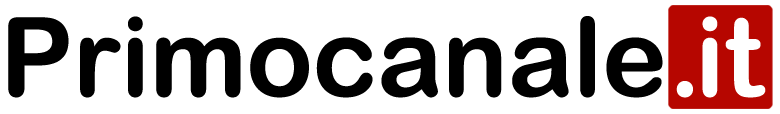
IL COMMENTO
-
Carlo Buttaroni*
Giovedì 03 Aprile 2025
-
Luigi Leone
Lunedì 31 Marzo 2025
leggi tutti i commentiLa scienza dei sondaggi: ecco come lavoriamo per raccontare la realtà insieme a Primocanale
La Costituzione, Salis in Lottomatica e la politica di cui non puoi fidarti