
GENOVA - "Abbiamo lasciato lì il cuore e l’intenzione è quella di tornare". Sono queste le parole con cui inizia il racconto di Stefano Rebora, presidente della Ong Music for Peace, uno degli 83 italiani che sono stati fatti rimpatriare dal Sudan dove si trovava per un'operazione umanitaria in seguito allo scoppio di una guerra civile tra l'attuale Governo militare del Paese guidato da Abdel-Fattah Al-Burhan (SAF, Sudanese Armed Forces) contro i paramilitari delle Forze di sostegno rapido (RSF, Rapid Support Forces) guidate dal suo numero due del, Mohamed Hamdan Dagalo. "Abbiamo lasciato una situazione devastante - racconta -, siamo arrivati con una nazione che accoglieva e abbiamo lasciato una nazione che è da accogliere". Il Sudan infatti si trova tra Ciad, Darfour, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, "tutti stati in guerra o di guerre appena concluse, di cui accoglieva i profughi che ora cercano di tornare nei paesi d'origine. Ora anche i sudanesi sono da accogliere" spiega Rebora, che era andato in Sudan insieme ad altre quattro persone: il project manager Pietro Biondi, la social media manager Chiara Gardella, l'executive manager Valentina Gallo, coniuge di Rebora, e loro figlio Athos, di 8 anni. "Ho avuto paura per mio figlio, lo avevo portato in un contesto che per me era tranquillo - racconta Rebora -. Ha fatto dei video per sua scelta, voleva comunicare coi suoi compagni di scuola. Valentina nella quotidianità è mia moglie ma in associazione è una collega molto brava di cui ho bisogno per portare avanti il lavoro. Ma lì la mia famiglia era tutta Music for Peace, come tutto lo staff che lavorava con noi a Karthoum. Un pensiero va a tutti i locali che assistevamo, che hanno dimostrato affetto nei nostri confronti e che ci hanno guidati aiutandoci a trovare i check point, a trovare cibo e acqua. Non avevamo grosse scorte, solo grazie all'aiuto dei locali abbiamo trovato alcuni magazzini per rifornirci".
Il messaggio che arriva dall'associazione è chiaro, "la cosa importante ora è vedere cosa ne sarà del popolo sudanese" dichiarano Rebora e Gallo, che invita i giornalisti ad accendere ancora di più le telecamere sulla situazione del Sudan. "Per noi mettere piede a Ciampino è stato un tonfo assordante - racconta Valentina Gallo - perché noi eravamo qui e gli altri no. Chiediamo il vostro aiuto per denunciare questa tragedia umana per tanti motivi: noi avevamo del cibo da razionare ma gli altri? E purtroppo ci sono state persone che si sono fatte scudo con dei bambini". Gallo si riferisce ai fatti del 16 aprile: le forze armate guidate da Dagalo hanno occupato la sede dell'Ong Sos Village, che collabora con Music for Peace e ospita bambini orfani, perché le forze governative non correrebbero il rischio di attaccare un'area con ospiti così fragili. Nella sede locale peraltro si trovano anche i magazzini e l'ambulatorio di Music for Peace, che potrebbero essere stati saccheggiati.
"Spero che l'eco mediatica non si spenga: la notizia non è il rientro degli italiani - aggiunge Rebora -. Che destino avranno questi milioni di persone? Il 90% della popolazione vive in condizioni di estrema povertà. Ora sarà un tutti contro tutti: chi lotta per il potere, chi per il denaro e ora chi lotta per sopravvivere. Poi il quarto punto è la società civile che vuole un processo di democratizzazione". Secondo Rebora c'è bisogno di "un corridoio per cercare di continuare a sostenere la popolazione civile, inoltre chiediamo ai governi di mettere in atto le azioni possibili per far cessare il fuoco e arrivare ad un Governo di unità nazionale. Noi dividiamo i migranti in economici, politici e rifugiati ma questa distinzione non esiste, fino a due giorni fa i migranti sudanesi erano economici, ora non più. O i Curdi, prima terroristi, poi eroi e poi di nuovo terroristi. Non dobbiamo classificare le persone in base al nostro modo di ragionare, dobbiamo viverla sul campo".
Gli scontri si sono svolti nei cosiddetti 'quartieri safe' perché sono quelli con i centri del potere: palazzi governativi, aeroporto, banche. "Eravamo tranquilli, il sabato è festa e volevamo concederci un giro, poi il pomeriggio avremmo raggiunto i magazzini. La mattina però sentiamo i primi spari e nel giro di poche ore siamo passati ai tank e all’aviazione nel pieno centro della città in una guerra senza confine, dove un quartiere era controllato dai governativi e quello dopo dalle Rsf, bisognava fare la massima attenzione" raccontano gli attivisti, che hanno dovuto affrontare numerose difficoltà: "Abbiamo deciso di raggiungere la residenza dell’ambasciatore a circa 5km di distanza ma abbiamo avuto un inconveniente: la macchina non partiva, batteria scarica. Per fortuna un sudanese ci ha prestato la sua batteria. Per fare cinque chilometri abbiamo impiegato due ore e mezza proprio per i problemi legati al controllo dei quartieri: quando vedevi un conflitto a fuoco dovevi cambiare rapidamente strada senza però perdere il senso dell’orientamento. Siamo anche andati a prendere dei colleghi che non avevano mezzi. Paura? No - dichiara Rebora -, la paura l'abbiamo solo per quello che abbiamo lasciato. Bisognava essere razionali e prudenti, non istintivi". "Ricordava il Covid perché eravamo chiusi in casa, però non riesci a dormire perché hai paura oppure alle 4 ti svegliano i bombardamenti - racconta Pietro Biondi -. I sudanesi hanno una sorta di abitudine a vedere i militari per strada, a non avere cibo, a non potersi muovere. La tranquillità con cui gestivano questa situazione, che andavano a bere un caffè dai vicini, dice molto sulla situazione del paese", che aveva già subìto un golpe nel 2021, quando si era insediato l'attuale Governo.
L'attività della Ong in Sudan però non si ferma: "La missione di Music for Peace era quella di sostenere con aiuti alimentari la popolazione civile e potenziare il sistema sanitario con medicinali e attrezzature mediche - spiega Rebora -. Lo facevamo anche quest'anno ma in modo più strutturato: prima era mordi e fuggi, ora la durata era di un anno, avevamo preso in carico mille famiglie che porteremo comunque avanti per tutto l'anno con lo staff locale e cercheremo di insegnare una struttura organizzativa per il supporto emergenziale per le famiglie e anche insegnare piccoli mestieri. Porteremo avanti l'obiettivo, da lì è arrivata la scelta di uscire dal Paese. Non potevamo lavorare e avremmo messo a rischio il nostro staff locale rendendolo ulteriormente vulnerabile, dal momento che chi compie aiuti umanitari viene identificato come una persona che ha scorte di cibo. Li guidiamo da Genova ma torneremo lì".
 12° C
12° C LIVE
LIVE



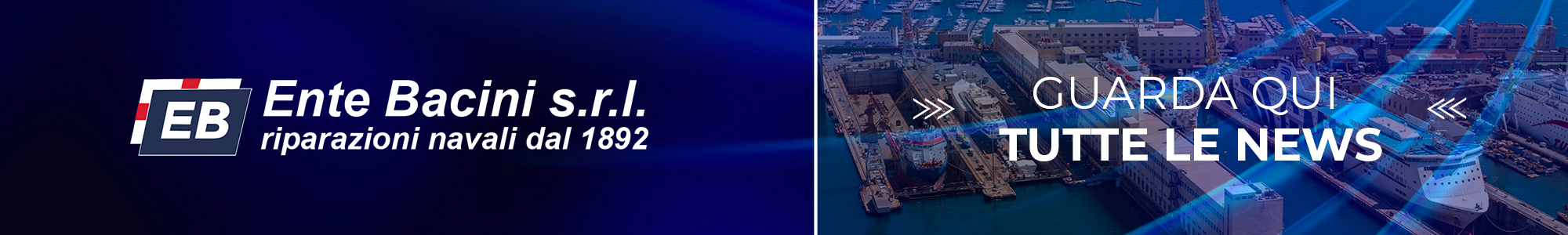


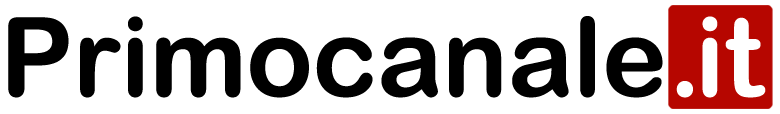
IL COMMENTO
-
Luigi Leone
Lunedì 31 Marzo 2025
-
Mario Paternostro
Domenica 30 Marzo 2025
leggi tutti i commentiLa Costituzione, Salis in Lottomatica e la politica di cui non puoi fidarti
Ti ricordi Bilancia? 17 omicidi in sette mesi di terrore