
Il nuovo mostro di cui si discute ciclicamente in città è l’Overtourism, Genova sarebbe invasa da troppi turisti, se ne parla per Boccadasse, per il centro storico (complice il fenomeno degli affitti brevi e di Airbnb, perfino per spianata Castelletto invasa da troppi pullman). Nella discussione sul turismo occorre richiamare almeno tre punti fondamentali:
1) A differenza delle riviere liguri, Genova non era una città turistica ed ha dovuto a poco, a poco inventarsi un nuovo ruolo in questo comparto economico;
2) Molte risorse economiche (e non solo economiche) sono state investite, soprattutto per le Manifestazioni per i 500 anni della scoperta del 1992, ma anche negli anni successivi per sviluppare il settore turistico;
3) Quest’ultimo si è spesso coniugato con una valorizzazione attiva del porto antico, del centro antico e, più in generale, con una valorizzazione storico-culturale della città di grandi potenzialità intrinseche (palazzi, ville, opere d’arte, patrimoni portuali).
Genova non era una città turistica, non era una meta per gli stranieri in Italia, così come non lo era Torino, le due città erano viste come città operaie, città delle tute blu e a partire dai primi anni Ottanta un po’ grigie e in decline. Il loro enorme patrimonio era poco valorizzato rispetto alle enormi caratteristiche per mettere in moto flussi di visitatori. In particolare Genova era una città di tute blu, dei camalli del porto, di un lavoro duro, una grande “città d’acciaio” per l’ampia presenza della siderurgia e della cantieristica.
La crisi che colpisce il comparto siderurgico all’inizio degli anni Ottanta porta al drastico ridimensionamento dei luoghi della produzione e degli addetti; con le difficoltà di questo settore sembra improvvisamente venir meno un sistema che per molti anni ha assicurato possibilità lavorative e buoni livelli di reddito. Anche altri settori industriali, in gran parte legati alle Partecipazioni Statali, entrano in uno stato di incertezza, l’area a Ponente della città subisce gli effetti più pesanti di questa crisi che non è solo economica, ma soprattutto sociale. Inizia un periodo di profonde incertezze e di timori, combattuto tra una difesa dell’esistente sempre più inadeguata e una faticosa ricerca di una nuova identità e di un nuovo ruolo per Genova.
Nel clima di pesante smarrimento che attraversa i primi anni Ottanta il tema della transizione verso una realtà post industriale è oggetto di numerosi convegni che vedono il coinvolgimento di istituti di ricerca. Entrano a far parte del dibattito locale alcune tematiche che riguardano la presa d’atto della crisi industriale, i rapporti conflittuali fra attività produttive e ambiente, le nuove possibili relazioni con la ricerca. In quegli anni un progetto per l’insediamento di Disneyland a Genova fu considerato una sorta di boutade. I contrari, soprattutto sindacalisti e politici, temevano consideravano il progetto un affronto alla dignità della classe operaia che da circa un secolo caratterizzava la città.
Ma il tempo non si può fermare e si fa progressivamente strada la consapevolezza che le risorse culturali, ambientali e paesistiche della città, opportunamente riscoperte e valorizzate, potrebbero rappresentare uno dei nuovi settori su cui puntare per un rilancio, tenendo anche conto dei flussi turistici assai rilevanti che si sviluppano in alcune realtà delle riviere liguri.
Nell’inverno 1984 la giunta comunale affida all’architetto Renzo Piano il primo incarico per “riflettere” circa i modi e i luoghi per creare l’esposizione colombiana del 1992 (nell’ambito dei festeggiamenti per il cinquecentenario della scoperta dell’America). Il fatto di realizzarla nel porto antico, è all’inizio un’ipotesi tutt’altro che scontata, l’amministrazione pensa ad un apposito spazio espositivo fuori dalla città o ad una piattaforma sul mare. Progressivamente ci si rende conto che il centro storico e l’area del porto antico costruiscono il luogo ideale per la manifestazione e che le opere realizzate, anche dopo l’evento, possano costituire il baricentro di nuove ipotesi di sviluppo per la città. Si avvia un percorso di recupero del waterfront che permetta alla città di ritrovare il suo affaccio sul mare e di fare da volano a processi di riqualificazione nel centro storico.
Il resto è storia più recente, di cui possiamo valutare esiti rilevanti e problematicità, ma Genova è una realtà turistica consolidata, ricordiamo quante fatiche e quante risorse pubbliche (ma anche umane, relazionali, sindacali ecc ecc) abbiamo dovuto impiegare per mettere in moto i processi turistici che oggi talvolta contestiamo.
*Francesco Gastaldi, professore associato di Urbanistica, Università IUAV di Venezia
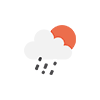 16° C
16° C LIVE
LIVE





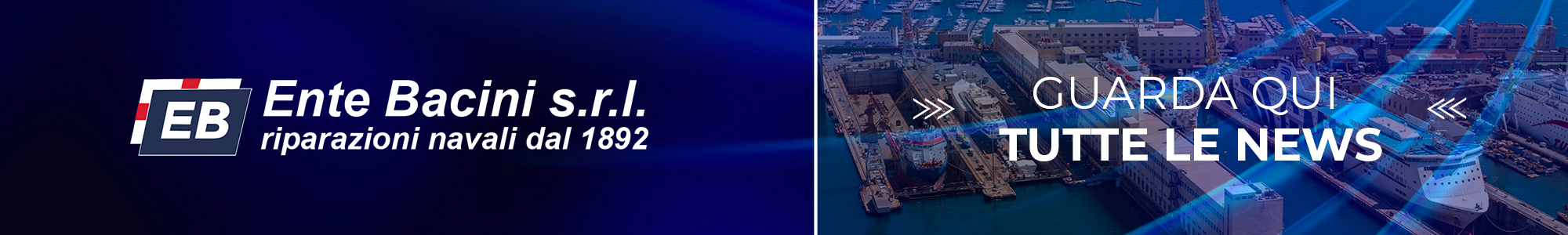

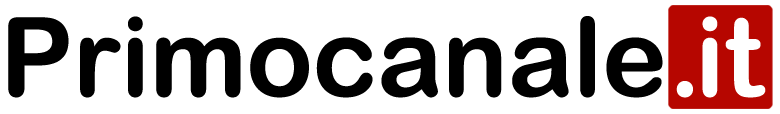
IL COMMENTO
-
Francesco Gastaldi*
Mercoledì 16 Aprile 2025
-
Luigi Leone
Lunedì 14 Aprile 2025
leggi tutti i commentiGenova e il Turismo, un rapporto complesso con i camerieri
Leonardo, Fincantieri e la guerra: l'etica non può essere solo italiana